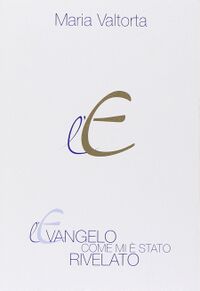Diaconi
I diaconi (il cui termine proviene dal greco diákonos, che significa “servo” e che, nell’uso antico, poteva riferirsi sia a un alto funzionario sia a un semplice domestico), furono istituiti nella Chiesa dopo il termine della vita terrena di Gesù Cristo e sono menzionati negli Atti degli Apostoli[1], nella lettera ai Filippesi[2] e nella lettera a Timoteo[3]. Storicamente, il loro ruolo specifico fu incorporato al sacerdozio prima di tornare a essere un ministero distinto, riscuotendo un crescente successo nei paesi del cristianesimo antico. Anche nell’Opera di Maria Valtorta, negli ultimissimi capitoli, viene menzionato il martirio di Stefano, nel quale egli è chiaramente indicato come uno dei sette diaconi. Questo riferimento porta a interrogarsi sui possibili legami tra l’Opera di Maria Valtorta e l’istituzione dei diaconi.
I Sette diaconi della comunità di Gerusalemme
La nomina dei primi Sette Diaconi della comunità di Gerusalemme è descritta negli Atti degli Apostoli:
«Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: “Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola”. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani». (Atti 6,2-6)
Secondo le fonti storiche, la lapidazione di Santo Stefano avvenne poco dopo la Pentecoste, nei primissimi tempi della Chiesa della comunità di Gerusalemme. Saulo (il futuro apostolo Paolo), allora ancora fariseo a Gerusalemme, fu testimone della lapidazione di Stefano, prima di diventare il feroce persecutore dei cristiani che avrebbe poi incontrato Cristo sulla via di Damasco. Gli studiosi collocano il martirio di Stefano circa due o tre anni dopo la crocifissione, e la Chiesa lo commemora liturgicamente il 26 dicembre.
Dei sette diaconi, solo tre sono storicamente attestati con certezza: Stefano, Filippo e Nicola di Antiochia (che Maria Valtorta chiama Nicolai di Antiochia). Gli altri cinque sono conosciuti solo attraverso agiografie posteriori (Pròcoro e Timone) o restano praticamente sconosciuti (Nicànore e Parmenàs). Tuttavia, il Martirologio Romano li menziona tutti.
Benché fossero destinati a compiti materiali, questi diaconi si presentano come evangelizzatori particolarmente ispirati, come mostrano l’episodio della sinagoga dei Libertini[4] (Stefano) o quello dell’eunuco, alto funzionario della regina Candace[5] (Filippo). Sono “uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza”[6], che conoscono bene la Scrittura sia nello spirito che nella lettera.
Tutti e sette portano un nome di origine greca, adatto a rassicurare i fratelli “di lingua greca”, i quali “mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell'assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove”[7].
- Stefano: Stephanos – “incoronato” o “corona” (simbolo di vittoria o di martirio).
- Filippo: Philippos – “colui che ama i cavalli” (philos = amico, hippos = cavallo).
- Pròcoro: Prochoros – “colui che guida la danza” oppure “capo del coro”.
- Nicànore: Nikanor – “vittorioso” (nikê = vittoria, anêr = uomo).
- Timone: Timôn – “che onora” oppure “rispettoso” (timê = onore).
- Parmenàs: Parmenas – etimologia meno chiara, forse legata a parmenô (perseverare) o a un nome persiano ellenizzato.
- Nicola: Nikólaos – “vittorioso tra il popolo” (nikê = vittoria, laos = popolo).
Possibili legami con l’Opera di Maria Valtorta
A parte il riferimento al diacono Stefano, nel “L'Evangelo come mi è stato rivelato” di Maria Valtorta, non vi sono menzioni esplicite dei sette diaconi che vennero ordinati nella Chiesa cristiana primitiva per coadiuvare gli Apostoli. Tuttavia, alcune somiglianze di nomi, profili e contesti hanno portato gli autori del “Dizionario dei personaggi dell'Evangelo secondo Maria Valtorta”[8] a ipotizzare che almeno quattro diaconi su sette possano essere identificati nell’Opera:
- Stefano, esplicitamente citato come diacono[9], un “uomo pieno di fede e di Spirito Santo”, come lo descrivono gli Atti degli Apostoli[10], in piena coerenza con il ritratto che ne fa Gesù nell’Opera di Maria Valtorta e con il destino che lo attende[11]. Pur essendo stato allievo di Gamaliele, non è la Giudea o la Galilea che egli evangelizza, ma le nazioni[12].
- Nicolai di Antiochia, proselito[13]. La somiglianza di nome, di origine e di condizione sostiene l’identificazione del personaggio di Maria Valtorta con il diacono Nicola. È un nazireo[14], consolatore di Gesù[15], interamente dedicato alla sua missione[16]. In seguito fu accusato di aver fondato un movimento eretico citato nell’Apocalisse[17], accusa dalla quale venne poi discolpato.
- Filippo di Arbela. È un temperamento forte che, come Saulo o Maria di Magdala, si dedica a vie sbagliate prima di convertirsi radicalmente dopo l’incontro con Gesù. L’opera mette in risalto i suoi talenti, che lo predispongono all’attività evangelizzatrice testimoniata negli Atti degli Apostoli. Uomo della Decapoli (Alta Perea), percorre le terre trascurate della Samaria e della Fenicia (Gaza), prima di stabilirsi a Cesarea, porto cosmopolita ai confini tra Galilea e Samaria, dove riceve la visita di Paolo[18].
- Timoneo di Aera. Questo nome è raro e non ha omonimi nella Bibbia. È il giovane capo della sinagoga del paese presso l'Acqua Speciosa. Le tradizioni agiografiche[19] lo ricordano come uno dei “70 discepoli” — ruolo che ricopre anche nell’opera di Maria Valtorta — e come “vescovo di Bostra”, che richiama Bozra, un luogo remoto come Aera, sua terra d’origine.
Origine del nome
La parola “diacono” deriva dal greco diakonos (servitore), che può indicare tanto un alto funzionario quanto un domestico.
Maria Valtorta non parla ancora dei diaconi come istituzione — sono presenti solo come “futuri diaconi”.
Approfondimenti biblici
Nelle epistole di san Paolo, i servi di Dio (o del diavolo) sono chiamati diakonos. Tuttavia in due scritti questo termine assume un rilievo particolare:
- Nell'Epistola ai Filippesi[20] egli menziona e dispone i diaconi in rapporto agli episcopi:
«Paolo e Timòteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi: grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo». (Fil 1,1-2)
Secondo il sacerdote cattolico francese Émile Osty, biblista e traduttore della Bibbia, i vescovi menzionati da san Paolo non vanno intesi come vescovi nel senso attuale del termine, ma piuttosto come i responsabili o i sorveglianti della comunità, figure che solo in seguito si sarebbero distinte gerarchicamente dai vescovi.
- Nella Prima Lettera a Timoteo[21], san Paolo elenca le qualità richieste per la nomina dei diaconi:
«Allo stesso modo i diaconi siano persone degne e sincere nel parlare, moderati nell'uso del vino e non avidi di guadagni disonesti, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. Allo stesso modo le donne siano persone degne, non maldicenti, sobrie, fedeli in tutto. I diaconi siano mariti di una sola donna e capaci di guidare bene i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro ministero, si acquisteranno un grado degno di onore e un grande coraggio nella fede in Cristo Gesù». (1Tm 3,8-13)
Nel corso della storia, alcuni ministeri o servizi della Chiesa furono affidati ai laici, riducendo il diacono a un semplice grado del sacerdozio. Nel Medioevo la funzione propria del diaconato andò perduta, e per molti secoli esso rimase soltanto una tappa transitoria verso l’ordinazione sacerdotale. Uno degli ultimi diaconi “nel senso stretto” sarebbe stato san Francesco d’Assisi, che non era sacerdote. Con il Concilio Vaticano II, il diaconato fu istituito come “un grado proprio e permanente della gerarchia”. È il primo dei tre gradi del sacramento dell'Ordine[22]:
«L'Ordine è il sacramento grazie al quale la missione affidata da Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere esercitata nella Chiesa sino alla fine dei tempi: è, dunque, il sacramento del ministero apostolico. Comporta tre gradi: l'Episcopato, il presbiterato e il diaconato». (Catechismo della Chiesa Cattolica, §1536)
Il diacono è abilitato a servire il popolo di Dio nel ministero della liturgia, della parola e della carità. Ha la facoltà di presiedere la celebrazione di alcuni sacramenti. Il diaconato può essere conferito anche a un uomo sposato (ma è necessario il consenso della moglie), se l'uomo è celibe, dopo l'ordinazione diaconale non può più sposarsi. Accanto ai ministeri ordinati, esistono anche ministeri istituiti minori che possono essere affidati ai laici, come il lettorato[23], l’accolitato[24] e l’esorcistato[25].
Secondo la Lumen gentium[26], il diacono può: “amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura”. Tuttavia, il loro impegno principale rimane il servizio: “agli uffici di carità e di assistenza”.
Infine, secondo l’Annuario delle Statistiche della Chiesa, al 31 dicembre 2022 vi erano 50.159 diaconi nel mondo[27].
Note
- ↑ Atti 6,2-6
- ↑ Fil 1,1
- ↑ 1Tm 3,8-13
- ↑ At 6,8-11
- ↑ At 8,25-40
- ↑ At 6,3
- ↑ At 6,1
- ↑ “Dictionnaire des personnages de l’Évangile selon Maria Valtorta”, di René Laurentin, François-Michel Debroise e Jean-François Lavère, Edizioni Salvador (2012)
- ↑ EMV 645
- ↑ At 6,5
- ↑ EMV 354.5
- ↑ At 6,8-9
- ↑ coloro che si convertivano dal paganesimo al giudaismo
- ↑ nell’Antico Testamento era una persona consacrata a Dio con un voto speciale, che comportava segni esteriori come l’astensione dal vino e il non tagliare i capelli (Nm 6,1-21).
- ↑ EMV 638.19
- ↑ EMV 355.6
- ↑ Ap 2,6 e Ap 2,15
- ↑ At 21,8
- ↑ Lista attribuita a Ippolito di Roma | Lista attribuita a Doroteo di Tiro | Pseudo-Epifanio.
- ↑ Fil 1,1-2
- ↑ 1Tm 3,8-13
- ↑ CCC §1536
- ↑ proclamare le letture bibliche durante la liturgia
- ↑ il servizio di aiuto al sacerdote durante la liturgia
- ↑ servizio di assistenza al vescovo o al presbitero nei riti di esorcismo, oggi soppresso
- ↑ Lumen gentium §29
- ↑ Vedi: Agenzia Fides, le statistiche della Chiesa cattolica 2024